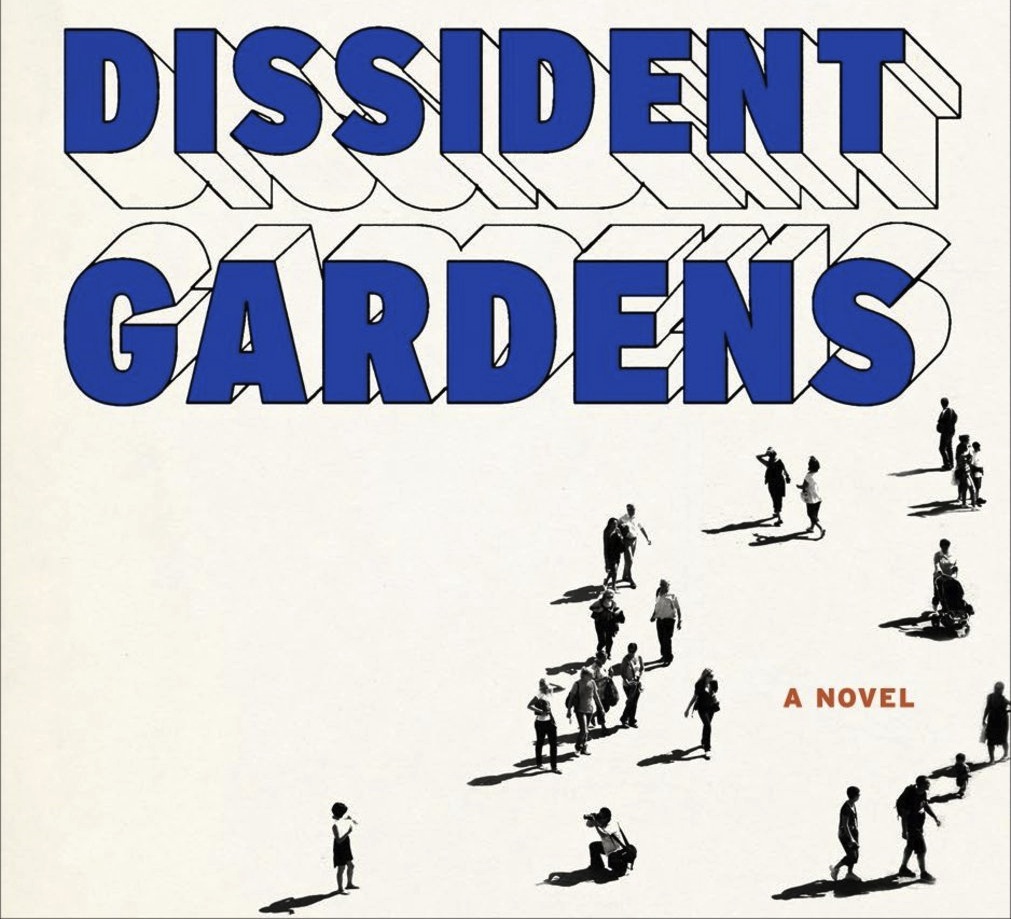Giulia Caminito, trentatreenne romana giunta al suo terzo romanzo in cinque anni, ha scritto una storia dolorosa, tagliente, aspra. Una storia in prima persona e al presente, sullo sfondo e in sottofondo il lago di Bracciano e Anguillara Sabazia, perché «sono cresciuta lì e ho un rapporto viscerale con il lago e con il paese, dove ho conosciuto le persone più importanti della mia vita».
Giulia Caminito, trentatreenne romana giunta al suo terzo romanzo in cinque anni, ha scritto una storia dolorosa, tagliente, aspra. Una storia in prima persona e al presente, sullo sfondo e in sottofondo il lago di Bracciano e Anguillara Sabazia, perché «sono cresciuta lì e ho un rapporto viscerale con il lago e con il paese, dove ho conosciuto le persone più importanti della mia vita».
Però L’acqua del lago non è mai dolce non è una biografia, un’autobiografia o un’autofiction, avverte l’autrice. È un romanzo che assorbe, digerisce e restituisce brandelli di vita reale, non importa di chi, perché il vuoto ordinario dell’adolescenza, la lotta quotidiana per la sopravvivenza, le discriminazioni imposte dal censo e dal pregiudizio, la distanza siderale tra città e provincia, la ricerca di un “posto” nel mondo o la rinuncia, sono temi universali.
Con voce incalzante, scandita, stentorea, inequivocabile Caminito ci porta in riva al lago, l’acqua immobile e torbida, sul fondo solo fango, alghe, vetri rotti e leggende, in superficie tutto quello che riguarda la vita di una bambina che si fa donna: promesse tradite, amori consumati e perduti, desideri mancati. Affida la parola a Gaia, voce narrante, che studia con ostinazione e furore perché così vuole sua madre, che legge molti libri, frequenta «il liceo classico dei ricchi», si laurea in filosofia, ma resta sempre «donna spezzata e opaca, quella che si rinfrange sulla superficie e la vedi sempre a metà». Che ci racconta di Antonia, la madre, una vera combattente, un’Enea al femminile che porta in salvo sulle spalle una famiglia intera, da quando il marito si è spezzato le gambe in cantiere. Antonia lavora, organizza, pulisce, impartisce, accudisce, punisce, decide, concede, toglie, non si arrende. Che ci parla, ancora, di tutto il resto, le “voci” del paese e i muri scrostati della scuola, le feste di capodanno e di compleanno, capelli e pesci rossi, cinghiali e cigni, incendi appiccati e fari spenti nella notte.
Una storia che si aggroviglia e si dipana con scrittura essenziale ed efficace, che lascia sotto la superficie ciò di cui si nutre, che non concede pause né infingimenti.

Giulia Caminito. Foto profilo Facebook
Sei nata a Roma, hai trentatré anni, hai una laurea in filosofia politica, fai l’editor, il tuo primo libro è uscito nel 2016. Che cosa puoi aggiungere a questa breve presentazione?
Sono per le biografie brevi quindi mi sembra giusto così.
A cinque anni dal tuo esordio letterario hai già all’attivo tre romanzi e una raccolta di racconti. Scrivi libri per necessità, vocazione, casualità?
Scrivo molto, troppo, per tante ragioni, i tre romanzi però sono nati proprio da una mia forte voglia di raccontare quelle storie, non so se si possa dire vocazione, certo casualità a volte perché certe intuizioni su quello che scriverai arrivano per caso e poi inizi a coltivarle e nutrirle. Necessità probabilmente sì, sia perché è l’unica cosa che riempie la mia vita (scrivere, leggere, occuparmi di libri), sia perché certe volte sento le mani prudere e devo scrivere le idee che girano per la testa, anche solo per ricordarle. Scrivo moltissimi appunti, dialoghi, citazioni, sogni, scalette, liste, tracce e poi le tengo lì in attesa di un inizio o semplicemente a riempire la mia soffitta di scritture possibili.
La forma racconto è in genere quella prescelta per mettersi alla prova e farsi conoscere. C’è chi, a torto, considera il racconto una forma di scrittura meno impegnativa del romanzo, più semplice da gestire. Tra racconto e romanzo qual è, se esiste una preferenza, il genere a te più congeniale?
Mi piacciono entrambi i generi, i racconti per me sono un luogo di sperimentazione sia linguistica sia tematica, amo scriverli, sono più diretti e meno mediati dal progetto, mentre i romanzi sono più faticosi, impegnativi, prevedono un grande sforzo per focalizzarsi sulla storia scelta, sulla sua organizzazione, sul tipo di scrittura, sull’omogeneità e molti altri fattori.
Come lettrice ai miei occhi sono equivalenti e come autrice entrambi mi danno soddisfazioni diverse in corso di stesura. Amo molto anche le forme ancora più brevi come gli epistolari, le raccolte di frammenti o appunti, la poesia. Uno dei miei libri preferiti di sempre è Passages di Walter Benjamin, essenzialmente tantissimi appunti raccolti su vari argomenti in funzione di un libro che non è mai stato scritto.
In merito al modo in cui scrivi hai spiegato che rileggi molte volte la prima stesura, anche ad alta voce. Questo particolare mi riporta alla tua esperienza di editor e giurata nel famoso concorso letterario 8×8 organizzato da Oblique Studio, dove viene valutata anche la resa “vocale” del racconto. L’incontro con 8×8 ha influenzato la tua “voce” di scrittrice e, in caso affermativo, come?
Non ci ho mai pensato, è un concorso che mi piace molto perché mi ha permesso di incontrare autori e autrici giovani con cui sono rimasta in contatto negli anni. Con una di loro, Martina Tiberti, sono diventata amica e ha scritto la drammaturgia di una mia raccolta di racconti, anni dopo la serata del concorso. Leggere ad alta voce a me serve non per considerare l’interpretazione, come accade nel concorso, ma per capire il ritmo, le pause, gli errori possibili. Leggendo ad alta voce ci rendiamo conto delle mancanze di fiati, delle lungaggini, dei periodi che non girano bene, per questo se voglio controllare qualcosa che ho scritto oltre a leggerlo su vari schermi e stampato, lo leggo ad alta voce.
La tua “voce”, leggendo questo romanzo, è incalzante, scandita, stentorea, inequivocabile. Si traduce in una scrittura essenziale, efficace, a tratti tagliente, che lascia sotto la superficie ciò di cui si nutre. Insomma, la tua scrittura è come l’acqua del lago che, tra l’altro, non è mai dolce. Da dove nasce tutto questo?
Nasce da alcuni anni di lavoro sullo stile, volevo infatti creare un mio linguaggio riconoscibile in questo nuovo romanzo. Credo infatti di amare, come lettrice, due tipi di scrittura: o quella piana, elegante delle bellissime descrizioni esterne e interne, dei riferimenti letterari adatti e delle narrazioni a tutto tondo; oppure mi piace trovare una lingua peculiare nei libri, una impronta. Io di natura non sono portata al primo tipo di scrittura, ma da sempre mi sento più vicina alla seconda, tendo infatti a condensare, accumulare, listare mentre scrivo. Sono pochi i campi lunghi nella mia scrittura, molte invece le insistenze sull’uso del vocabolario e sui dettagli. Credo faccia parte proprio di me e di come mi viene di parlare del mondo sulla pagina scritta, quindi cerco di elaborare sempre di più questo mio stile in modo che sia adatto secondo me al romanzo che in quel momento sto scrivendo. Qui mi serviva un io carico, giudicante, tragico, deciso, e su quello ho lavorato con la scrittura e lo stile.

Anguillara Sabazia. Foto di Alessio Trerotoli Photographer (2013)
Nella nota conclusiva di L’acqua del lago non è mai dolce hai scritto che la storia «non è una biografia, né un’autobiografia, né un’autofiction». Puoi spiegarci meglio come è stata la gestazione del libro, come è nato l’incontro con l’editore e tutto quello che è accaduto fino alla pubblicazione?
L’incontro con l’editore è avvenuto anni fa, nel 2014 circa, quando ho iniziato a lavorare a un progetto web per Giunti. Intanto avevo cominciato già da qualche anno a scrivere La Grande A e a metà stesura lo mandai in casa editrice per un parere, loro mi dissero che erano interessati, quindi io finii e da lì iniziammo l’iter per la pubblicazione. Sono rimasta sempre nello stesso gruppo editoriale, ma quando Giunti ha comprato Bompiani, il direttore editoriale Antonio Franchini mi ha spostata in Bompiani perché stavano riorganizzando le linee editoriali. E così sono arrivati gli altri due libri con Bompiani.
L’acqua del lago non è mai dolce è nato dopo due romanzi storici con la voglia di cambiare genere, buttarmi nel contemporaneo, provare a raccontare tutto in prima persona e travestire da autobiografia un romanzo che attraversasse temi di cui volevo parlare come il consumismo, la nuova povertà e la violenza giovanile. La nota è stata necessaria perché i riferimenti ai luoghi sono molto precisi e alcune parti della mia vita fanno da base alla narrazione, era importante quindi definire i confini e ribadire la mia voglia di costruire un io-romanzo e non un io-confessione.
Il primo protagonista del libro è il lago, quello di Bracciano, di fronte al quale si susseguono, tra la fine degli anni ’90 e la prima decade del 2000, accadimenti e accidenti dei vari personaggi. Le sue acque sono immobili e torbide, sul fondo giacciono fango, alghe, vetri rotti e leggende, ma su tutto incombe una menzogna. L’acqua del lago non è dolce, non lo è mai, come ci avverte il titolo, «ha il sapore della benzina, quando avvicini l’accendino prende fuoco». Un’immagine, tra le tante, che hai utilizzato per sparigliare gli stereotipi con cui siamo abituati a decrittare l’esistenza. Perché hai scelto il lago di Bracciano e Anguillara Sabazia a fare da sfondo e sottofondo alla tua storia?
Li ho scelti perché sono cresciuta lì e ho un rapporto viscerale con il lago e con il paese, dove ho conosciuto le persone più importanti della mia vita. Mi serviva uno scenario molto noto, che fosse per me attraversabile e sondabile in profondità, volevo che non fosse uno sfondo, ma una creatura tra le altre, che avesse una identità. Sapevo che prima o poi avrei scritto qualcosa sul lago, perché mi è troppo caro e famigliare, però non ero sicura lo avrei fatto in questo modo e adesso. Semplicemente quando ho iniziato ho capito che volevo provarci e mi sono tuffata.

Foto profilo Instagram di Giulia Caminito
Un’altra grande menzogna che il tuo romanzo sembra smascherare è quella sull’effetto riparatore della “cultura”. Viene frantumata l’idea che la conoscenza, lo studio, i libri siano gli unici antidoti agli effetti letali di un’esistenza indigente, priva di mezzi e opportunità. Gaia, protagonista e voce narrante, studia con ostinazione e furore perché così vuole sua madre, Antonia la rossa. Legge molti libri, frequenta «il liceo classico dei ricchi», si laurea in filosofia. Eppure, tutti gli strumenti culturali conquistati non le servono a molto. Gaia non si emancipa dalla povertà, dal dominio materiale e psicologico della madre, dall’incedere annoiato del paese, dall’immobilità limacciosa del lago che diventa attrazione quasi fatale. Di che cosa si tratta?
L’idea del libro è quella di porre l’interrogativo sulla possibilità che questa emancipazione sia diventata una chimera per molte e molti. È sempre più evidente infatti che i settori culturali e creativi sono meno disposti a pagare i neolaureati e i più giovani per lavorare. La conseguenza è che chi ha una famiglia in grado di sostenerlo riesce ad andare avanti, chi come la mia protagonista non ce l’ha deve abbandonare. Credo sia una realtà di fatto, che sta rendendo i lavori legati agli studi umanistici sempre più elitari, quando invece nel dopoguerra questa occupazione si era allargata. Era ancora possibile infatti per mia madre, figlia di un bigliettaio dell’Atac di Roma, riuscire a laurearsi in Lettere ed entrare nel sistema bibliotecario. Oggi tra i bandi pubblici bloccati, le aziende del settore sovraffollate, gli stages infiniti, la precarietà prolungata, l’editoria e il giornalismo (per fare due esempi) sono diventati nuovamente accessibili a pochi.
Lo smantellamento dell’assioma materno «se non studi non sei nessuno» trova piena attuazione nel fratello di Gaia, quel Mariano che a diciotto anni parte per il G8 di Genova contro il volere furioso di sua madre, fa l’anarchico, non studia e si sottrae. Eppure lo ritroviamo trasformato in adulto, capace di fare esattamente ciò che era necessario e risolutivo. Anche l’amico Cristiano manda in frantumi lo stereotipo. Lui che «reagisce al mondo e ai suoi affronti con freddezza, se c’è da fare lui fa», non importa se si tratta di svaligiare una casa di ricchi, di appiccare un incendio, di cacciare di frodo un cinghiale, di guidare a fari spenti sulla Braccianese o di contenere l’ira funesta di Gaia. Anche Cristiano ha completato la costruzione di sé e senza particolari supporti. Perché Gaia non ci riesce?
Mariano partecipa a una visione collettiva, politica del mondo e questo lo rende abitato da idee, visioni, lotte, sguardi. Cristiano vive coi piedi nel terreno dove è cresciuto, quello che vuole è portare avanti le tradizioni di famiglia, l’eredità feroce, contadina, sincera del paese, del suo lato più scuro, forse, ma anche più vero, autentico, vivo. Gaia si affanna sempre per le cose che non possiede, per le mode che non può seguire, per le persone che non la amano abbastanza, ma non racconta mai al lettore in cosa crede. Non credere è una grande maledizione secondo me. Ho affrontato il tema delle credenze in Un giorno verrà portando nella stessa storia la fede politica e la fede religiosa per parlare di quelle vite che si sono date uno scopo superiore rispetto alla propria affermazione individuale.
Per proseguire la ricerca di antinomie, il personaggio di Antonia la rossa (chiamata così per i suoi lunghi e fiammanti capelli) mi sembra quello più emblematico. È una vera combattente, un’Enea al femminile che porta in salvo sulle spalle una famiglia intera, da quando il marito si è spezzato le gambe in cantiere. Lei lavora, organizza, pulisce, impartisce, accudisce, punisce, decide, concede, toglie. La sua forza ha del sovrumano, la sua ostinazione la rende invincibile. Ma in questa frenetica lotta per la sopravvivenza quotidiana risultano banditi i sentimenti e ancor prima le parole. Fra Antonia, suo marito, i suoi figli, non circolano parole ma silenzi carichi di solitudine, oppure litigi furibondi. C’è un doloroso analfabetismo emotivo in questa famiglia così provata e indigente, ma non risulta che quelle più agiate – ce le fai incrociare di sfuggita – siano più attrezzate. Nessuno dei tuoi personaggi sembra capace di sorridere. Non c’è più spazio per una sospensione del dolore in questo mondo sgangherato e ferito?
C’è sicuramente spazio e in realtà nella lettura spero traspaia spesso anche una certa ironia, un sarcasmo strisciante. Il libro è volutamente caricato di alcuni sentimenti e li mette a tema, ma non esaurisce le esperienze del mondo reale, neanche quelle simili a Gaia e a sua madre. Il romanzo esaspera certe dinamiche per rendere più forte l’impatto e i pensieri che potrebbe generare.

Giulia Caminito. Foto profilo Instagram
Con due genitori bibliotecari è probabile che tu abbia avuto un accesso agevolato alla lettura. Parlando del tuo patrimonio letterario accumulato, puoi citare qualche titolo che ha avuto un impatto veramente significativo per la tua esperienza di lettrice e perché?
I tre libri che di solito nomino sono: L’opera struggente di un formidabile genio di Dave Eggers, La morte e la primavera di Mercé Rodoreda e Mio padre la rivoluzione di Davide Orecchio. Tre libri che non c’entrano nulla l’uno con l’altro, ma da ognuno ho imparato qualcosa nel corso della mia vita adulta sulla scrittura, sulla libertà, sullo stile, sui mondi possibili, sulla creatività e la bizzarria.
Concludo con la nostra domanda di rito. Che cosa c’è da leggere sul tuo comodino in questo momento?
In questo momento sto per finire Sembrava bellezza di Teresa Ciabatti e ho solo iniziato Dopo la pioggia di Chiara Mezzalama.
Giulia Caminito è nata a Roma nel 1988 e si è laureata in Filosofia politica. Oggi vive a Roma e lavora nell’editoria. Ha esordito nel 2016 con il romanzo La grande A (Giunti), vincitore del premio Bagutta opera prima e il premio Berto opera prima. Nel 2017 ha pubblicato la breve raccolta di racconti Guardavamo gli altri ballare il tango (Elliot) e nel 2019 Un giorno verrà (Bompiani), vincitore del Premio Fiesole Under 40). L’acqua del lago non è mai dolce è il suo terzo romanzo.





 Il cinema è tra le tue grandi passioni, sia come fruitore, sia come autore di sceneggiature. L’ultimo tuo libro sembra ispirato e dedicato a Bernardo Bertolucci. In che modo la tua scrittura cinematografica e la sua traduzione in immagini contaminano la tua scrittura letteraria, o viceversa?
Il cinema è tra le tue grandi passioni, sia come fruitore, sia come autore di sceneggiature. L’ultimo tuo libro sembra ispirato e dedicato a Bernardo Bertolucci. In che modo la tua scrittura cinematografica e la sua traduzione in immagini contaminano la tua scrittura letteraria, o viceversa?

 Lars Gustafsson – Il pomeriggio di un piastrellista (Iperborea)
Lars Gustafsson – Il pomeriggio di un piastrellista (Iperborea)
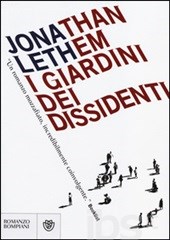 Il giardino dei dissidenti non è il capolavoro di Jonathan Lethem, ma la sua confusione ha un suono. Inside Llewin Davis è un film dei fratelli Coen uscito in Italia con il titolo A proposito di Davis e ispirato alla vita del cantautore Dave Van Ronk. Non è il miglior film dei fratelli Coen ma ha lo stesso suono della confusione de Il giardino dei dissidenti.
Il giardino dei dissidenti non è il capolavoro di Jonathan Lethem, ma la sua confusione ha un suono. Inside Llewin Davis è un film dei fratelli Coen uscito in Italia con il titolo A proposito di Davis e ispirato alla vita del cantautore Dave Van Ronk. Non è il miglior film dei fratelli Coen ma ha lo stesso suono della confusione de Il giardino dei dissidenti.